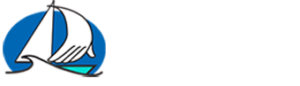La moneta umana
 «Chi te lo fa fare?». Questa è la domanda che mi sento rivolgere quando mi capita di raccontare della mia esperienza di volontariato. Una domanda che mi infastidisce perché nasconde, nell’interlocutore, l’indisponibilità mentale a comprendere questo tipo di esperienza. Rispondo con un ermetico «Boh! Non lo so» e cambio discorso. Altri, invece, hanno una reazione più empatica ma di uguale ambiguità: «Che bravo che sei a dedicarti agli altri! Ce ne vorrebbero tante di persone come te!». Sarà, ma io dietro questo sdolcinato encomio leggo il sotto testo d’una giustificazione alla propria indisponibilità, un «vorrei tanto farlo anch’io, ma proprio non posso». Ringrazio, sorrido e cambio discorso.
«Chi te lo fa fare?». Questa è la domanda che mi sento rivolgere quando mi capita di raccontare della mia esperienza di volontariato. Una domanda che mi infastidisce perché nasconde, nell’interlocutore, l’indisponibilità mentale a comprendere questo tipo di esperienza. Rispondo con un ermetico «Boh! Non lo so» e cambio discorso. Altri, invece, hanno una reazione più empatica ma di uguale ambiguità: «Che bravo che sei a dedicarti agli altri! Ce ne vorrebbero tante di persone come te!». Sarà, ma io dietro questo sdolcinato encomio leggo il sotto testo d’una giustificazione alla propria indisponibilità, un «vorrei tanto farlo anch’io, ma proprio non posso». Ringrazio, sorrido e cambio discorso.
La domanda che, invece, mi mette in difficoltà, che mi obbliga a riflettere e guardarmi dentro, è più rara e più diretta: «Perché lo fai?».
Già, perché lo faccio?
Non so cosa dire. Infatti, non ammettendo come plausibile il dozzinale buonismo sempre di moda, né un generico «dovere verso la collettività», tantomeno un non condiviso senso di colpa, mi ritrovo con nulla in mano. Non riesco a formulare alcunché di ragionevole alle orecchie del mio interlocutore, che rimane interdetto per il mio farfugliamento.
Mi verrebbe da dire: «Non so perché lo faccio, mi viene e basta». Che, mi rendo conto, lascerebbe ancor più insoddisfatto e inquieto l’ascoltatore, anche il più benevolo.
Mi spiace non poter essere più chiaro. Posso solo dire che la mia esperienza di vita è stata esattamente così da sempre: trovare modo e tempo per dedicarmi agli altri. Senza una ragione ufficiale, senza un progetto ideale. Mi sono sempre trovato coinvolto in modo naturale in esperienze di volontariato.
Con uno sforzo di memoria, a ritroso negli anni, il primo ricordo di volontariato l’ho rintracciato nella piccola parrocchia della periferia di Roma dove abitavo. Avevo circa dieci anni e c’era da organizzare la messa, portare sedie e altarino, convincere gli amichetti del quartiere a venire a cantare, ecc. Metabolizzati i furori mistici della preadolescenza, con lo stesso gruppo iniziammo ad organizzare giochi e attività nel quartiere. Lavoro volontario o semplice gioco? Non saprei, io però facevo e i compagnucci di strada, anziché giocare a flipper al baretto, venivano a fare le Olimpiadi ai Villini Alpi.
 Pochi anni dopo eccomi a fare il «leader» nei campeggi dell’YMCA. Il «Leader», parola impegnativa per un adolescente che doveva prendersi cura d’un manipolo di ragazzini poco più piccoli di lui, doveva assisterli nelle funzioni quotidiane, badare che non si rompessero la testa, e che vivessero in modo non traumatico il primo distacco dal nido familiare. Pulivo cessi, insegnavo kayak e nuoto, organizzavamo giochi e discussioni per quei giovani che le famiglie avevano scaricato in quel luogo nei difficili anni dell’eroina e del piombo. È stato bellissimo. La gioia di quell’esperienza, i legami umani che ne sono scaturiti, sono stati la moneta umana con la quale sono stato pagato in quello che a oggi mi pare persino difficile chiamare lavoro volontario. Eppure l’ho fatto per sei anni.
Pochi anni dopo eccomi a fare il «leader» nei campeggi dell’YMCA. Il «Leader», parola impegnativa per un adolescente che doveva prendersi cura d’un manipolo di ragazzini poco più piccoli di lui, doveva assisterli nelle funzioni quotidiane, badare che non si rompessero la testa, e che vivessero in modo non traumatico il primo distacco dal nido familiare. Pulivo cessi, insegnavo kayak e nuoto, organizzavamo giochi e discussioni per quei giovani che le famiglie avevano scaricato in quel luogo nei difficili anni dell’eroina e del piombo. È stato bellissimo. La gioia di quell’esperienza, i legami umani che ne sono scaturiti, sono stati la moneta umana con la quale sono stato pagato in quello che a oggi mi pare persino difficile chiamare lavoro volontario. Eppure l’ho fatto per sei anni.
La moneta umana è stata la medesima che mi ha retribuito nell’esperienza successiva, nella scuola di vela dei Glénans. Tra gli anni Settanta e Ottanta, dopo aver completato il percorso di allievo nella scuola francese, mi proposero di diventare moniteur.
C’est du benevol, est ce que ça te gene?, è stata la premessa. Non era un problema per me. Sarà s che non gli costavo nulla, o che ero bilingue o forse persino bravino, anche in questo caso ho fatto tutto il percorso fino a chef d’esquadre. Sempre come benevol, cioè volontario, per quasi dieci anni. A ripensarci oggi, mi vengono i brividi nel pensare ai rischi, anche penali, che mi son preso nel condurre gruppi di barche con inesperti su in Bretagna. Però, vedere un gruppo di smandrappati francesini terragnoli salire a bordo incapaci di distinguere le tangon da la baguette e vederli alla fine capaci di pilotare la barca mentre dormivo, è stata una soddisfazione impagabile. A loro ho dato il mio sapere, loro m’hanno ripagato con la meravigliosa sensazione d’essere inutile a bordo. Anche in questo caso, c’è stato uno scambio di moneta umana in cui, posso dirlo, ho sempre guadagnato.
Negli anni Novanta, poi, ho preso l’iniziativa in prima persona. Ho fondato un’associazione che prestava assistenza ai barboni e senzatetto della Stazione Termini a Roma. Ci siamo riuniti in una decina dal notaio a stendere lo statuto della Ronda della Solidarietà. Pasti caldi, coperte, un minimo di assistenza sanitaria, ma soprattutto il dialogo: nello statuto c’era scritto che il nostro obiettivo era stabilire uno scambio umano con quelle persone, non bastava solo un piatto di pasta precucinato nelle nostre case. Quelle persone non dovevano sentirsi sole. Dovevamo stragli vicino umanamente, talmente vicino che mi son preso più volte le piattole. È stata un’esperienza molto provante, un confronto con la disperazione e l’abiezione umana che non ha fatto sconti. È stato calarsi in un pozzo nero dove la vita s’è mostrata in tutta la sua indifferente crudeltà. Dopo tre anni non ho retto, non avevo più energie, non avevo più nulla di positivo da dare loro. E mi son ritirato, amareggiato per la mia incapacità.
Anni dopo, dopo aver metabolizzato quella che consideravo una sconfitta personale e ricaricato le batterie, mi sono affacciato nel volontariato politico. Mi sono bastate pochissime riunioni nella sezione di quartiere e qualche incontro con le autorità comunali per capire che non faceva per me: forte la sensazione che il mio volontariato fosse ascritto solo alla voce «costo lavoro: zero». Quindi, via a gambe levate. Volontario sì, ma non fesso.
Seduto in panchina, mi sono fatto coinvolgere in altre iniziative di volontariato sporadiche fino all’effimero, ma tant’è: ne avevo bisogno.
Poi, un giorno, leggo su una rivista di nautica inglese di un’esperienza che facevano in Olanda dove curavano le tossicodipendenze con serrati programmi di scuola nautica. È stata una illuminazione! «Lo voglio fare anch’io! Questa è la strada: curare con il mare il male di vivere! Sì, questo è per me», mi sono detto. Peccato che non avevo né una barca, né un punto di riferimento dove rivolgermi per avviare questa nuova esperienza di volontariato.
Finché, per uno strano giro di coincidenze e circostante, una persona che avevo conosciuto per tutt’altri motivi, e a cui devo molto, mi disse: «Perché non t’imbarchi su Oloferne?». Ho conosciuto così La Nave di Carta, dove il mio slancio di volontario sembra essere finalmente approdato. Ragazzi con difficoltà psico-fisiche, adolescenti problematici, studenti da formare, progetti di sviluppo e diffusione dell’arte marinara, programmi di cooperazione internazionale: c’è tutto quello che cercavo.
Tuttavia mi rimane in sospeso la domanda iniziale: perché lo faccio? Potrei andarmene in giro, bello bello, con la mia barchetta a fare apertivi nelle rade al tramonto. Invece mi trovo a sturare cessi, a rincorrere ragazzini in rivolta.
 Ebbene, francamente non lo so con certezza perché continuo. Se chiedessi a Freud potrebbe dirmi che il mio volontariato è una forma esasperata di narcisismo, un modo sottile e furbo per pormi meritoriamente all’attenzione degli altri. Se lo chiedessi a un credente magari oserebbe fino a dirmi che è la voce della Fede (che non ho). A me viene in mente un’altra considerazione, forse più prosaica ma realistica: lo faccio perché ci guadagno. Nella reciprocità dell’impegno di volontario, dove offro quel che ho e che so, dove ognuno offre ciò che può, avviene uno scambio di moneta umana che mi fa stare bene. Guadagno in felicità. E diciamo che può bastare così.
Ebbene, francamente non lo so con certezza perché continuo. Se chiedessi a Freud potrebbe dirmi che il mio volontariato è una forma esasperata di narcisismo, un modo sottile e furbo per pormi meritoriamente all’attenzione degli altri. Se lo chiedessi a un credente magari oserebbe fino a dirmi che è la voce della Fede (che non ho). A me viene in mente un’altra considerazione, forse più prosaica ma realistica: lo faccio perché ci guadagno. Nella reciprocità dell’impegno di volontario, dove offro quel che ho e che so, dove ognuno offre ciò che può, avviene uno scambio di moneta umana che mi fa stare bene. Guadagno in felicità. E diciamo che può bastare così.
Gabriele Mazzoleni